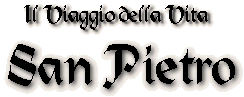
Il primo dei martyria cristiani, le costruzioni dedicate alla memoria dei martiri, sorse tra il 160 e il 200 nell'Ager Vaticanus, al centro di un ricco sepolcreto pagano. E' costituito da una spianata di 5 metri per 7, su cui si eleva il cosiddetto Trofeo di Pietro: il monumento, che celebra la vittoria dell'Apostolo sulla morte, è composto da una comune nicchia a timpano, preceduta da un'edicola. Secondo la tradizione, esso sorge esattamente sul luogo dove fu seppellito il santo, che subì il martirio a pochi passi di distanza, nel circo di Nerone: recenti indagini archeologiche sembrano confermare l'antica credenza, sebbene permanga un certo margine di incertezza.  Intorno al trofeo, che ancor oggi si conserva nella confessio, sotto il grande ciborio berniniano, l'Imperatore Costantino, tra il 319 e il 324, diede inizio a un'immensa basilica: un intero fianco del monte Vaticano venne tagliato per fare spazio, sopra l'antica necropoli pagana e il piccolo luogo di culto cristiano, a una gigantesca piattaforma di 290 metri per 90, su cui vennero gettate le fondamenta. Nonostante le difficoltà tecniche e le enormi dimensioni, l'edificio doveva già essere a buon punto tra il 329 e il 337, anno della morte di Costantino. Gli scavi, le descrizioni e le numerose testimonianze grafiche eseguite prima della sua scomparsa hanno permesso agli studiosi di ricostruire la chiesa del IV secolo, completamente trasformata a partire dal Cinquecento.
Intorno al trofeo, che ancor oggi si conserva nella confessio, sotto il grande ciborio berniniano, l'Imperatore Costantino, tra il 319 e il 324, diede inizio a un'immensa basilica: un intero fianco del monte Vaticano venne tagliato per fare spazio, sopra l'antica necropoli pagana e il piccolo luogo di culto cristiano, a una gigantesca piattaforma di 290 metri per 90, su cui vennero gettate le fondamenta. Nonostante le difficoltà tecniche e le enormi dimensioni, l'edificio doveva già essere a buon punto tra il 329 e il 337, anno della morte di Costantino. Gli scavi, le descrizioni e le numerose testimonianze grafiche eseguite prima della sua scomparsa hanno permesso agli studiosi di ricostruire la chiesa del IV secolo, completamente trasformata a partire dal Cinquecento.Quando nacque, San Pietro costituì una vera e propria eccezione: essa, infatti, era l'unica basilica costantiniana a riunire in se' la doppia funzione di martyrium e aula funeraria. Concepito in scala eccezionale, lungo 119 metri per 64, esso superava di molto la capienza di San Giovanni ed era in grado di accogliere sia le grandi masse di pellegrini accorsi a venerare il trofeo dell'apostolo, sia coloro che desideravano esservi tumulati accanto. La doppia destinazione è anche all'origine di una novità fondamentale dell'impianto, rimasta canonica nell'architettura ecclesiastica: la nuova basilica presentava, davanti al coro, un transetto continuo, con relativo arco di trionfo; questa lunga nave trasversa, dove erano accolte le folle dei credenti, veniva riservata al clero solo durante le funzioni liturgiche: il transetto era un luogo d'incontro con i fedeli, dove era accolta la tomba del martire, l'altare, gli scranni e le mensae per le offerte. Lo spazio longitudinale, invece, era un cimitero coperto, e il pavimento era costellato da lapidi tombali. La navata centrale, alta più di 30 metri, presentava su 44 fusti multicolori due lunghe trabeazioni di spoglio, la di sopra delle quali si aprivano 11 grandi finestre. 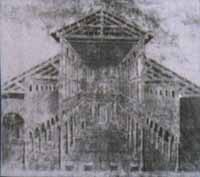 La basilica doveva essere preceduta da un nartece, che solo con papa Simplicio (468-483) assunse la forma di quadriportico: al centro, sotto un'edicola a baldacchino, si elevava l'enorme pigna bronzea del II secolo che ancor oggi è possibile ammirare nel cortile del Belvedere, in Vaticano. Sull'atrio si affacciava l'alto prospetto della chiesa: in semplice laterizio, si poneva in netta antitesi con il fasto dell'interno, che, non diversamente da San Giovanni e dalle altre imprese del IV secolo, rifulgeva di materiali preziosi e di splendidi arredi: basti qui ricordare la croce gemmata in oro massiccio del peso di 150 libbre. Al tempo di Leone Magno (440-461) la facciata si arricchì di una decorazione musiva, poi restaurata da Sergio I nell'VIII secolo e da Gregorio IX nel Duecento. A papa Leone si deve anche il grandioso ciclo ad affresco della navata mediana, di cui oggi non rimangono che testimonianze grafiche. Le scene raffiguravano, sulla destra, episodi dell'Antico Testamento e, dalla parte opposta, la Vita e la Passione di Cristo.
La basilica doveva essere preceduta da un nartece, che solo con papa Simplicio (468-483) assunse la forma di quadriportico: al centro, sotto un'edicola a baldacchino, si elevava l'enorme pigna bronzea del II secolo che ancor oggi è possibile ammirare nel cortile del Belvedere, in Vaticano. Sull'atrio si affacciava l'alto prospetto della chiesa: in semplice laterizio, si poneva in netta antitesi con il fasto dell'interno, che, non diversamente da San Giovanni e dalle altre imprese del IV secolo, rifulgeva di materiali preziosi e di splendidi arredi: basti qui ricordare la croce gemmata in oro massiccio del peso di 150 libbre. Al tempo di Leone Magno (440-461) la facciata si arricchì di una decorazione musiva, poi restaurata da Sergio I nell'VIII secolo e da Gregorio IX nel Duecento. A papa Leone si deve anche il grandioso ciclo ad affresco della navata mediana, di cui oggi non rimangono che testimonianze grafiche. Le scene raffiguravano, sulla destra, episodi dell'Antico Testamento e, dalla parte opposta, la Vita e la Passione di Cristo.A papa Simmaco (498-514) si devono i tre sacelli dedicati, come al Laterano, ai due San Giovanni e alla S. Croce, il restauro della rotonda di S. Andrea che, con il mausoleo di Onorio, sorgeva sul fianco sinistro della basilica. Dietro l'abside si trovava un altro sepolcro imperiale, appartenente alla famiglia degli Anici.  Gregorio Magno (590-605) dotò la chiesa di una cripta anulare che correva sotto la curva dell'abside e che, attraverso l'apertura di una finestrella, metteva i pellegrini in diretto contatto con la camera sepolcrale dell'apostolo. Il coro fu innalzato di circa un metro e mezzo e l'altar maggiore, incluso nel 1123 nella nuova struttura di Callisto II, venne così spostato sopra la confessio, in modo che il rito eucaristico potesse essere celebrato proprio sulla tomba di Pietro.
Gregorio Magno (590-605) dotò la chiesa di una cripta anulare che correva sotto la curva dell'abside e che, attraverso l'apertura di una finestrella, metteva i pellegrini in diretto contatto con la camera sepolcrale dell'apostolo. Il coro fu innalzato di circa un metro e mezzo e l'altar maggiore, incluso nel 1123 nella nuova struttura di Callisto II, venne così spostato sopra la confessio, in modo che il rito eucaristico potesse essere celebrato proprio sulla tomba di Pietro.All'inizio dell'VIII secolo Giovanni VII (705-707) fece costruire, vicino alla facciata, sulla destra, un oratorio dedicato alla Vergine, riccamente decorato con mosaici; fu distrutto dal Maderno all'inizio del Seicento. Nel 757 il mausoleo di Onorio venne trasformato nella chiesa di S. Petronilla, cara a Pipino il Breve e ai suoi successori da essere chiamata cappella regum francorum. In epoca carolingia fu costruito il seggio in legno di quercia noto come Cattedra di Pietro, cui vennero applicati degli avori tardo-antichi. Nell'846 la basilica subì l'oltraggio dei pirati saraceni, che saccheggiarono il tesoro: Leone IV (847-855) decise così di cingere con un borgo fortificato la Civitas Leonina intorno a San Pietro. Al tempo di Innocenzo III (1198-1216), la basilica venne sottoposta a una vasta campagna decorativa, protrattasi fino ai primi decenni del secolo successivo: l'abside fu dotata di un nuovo grande mosaico, che sostituì quello tardo antico: verso la metà del IV secolo, infatti, una decorazione figurata aveva preso il posto del semplice rivestimento in lamina d'oro di epoca costantiniana. Ne rimangono esigui frammenti di difficile attribuzione. Sempre nel XIII secolo venne anche rifatta la decorazione della facciata, di cui rimane un piccolo frammento con la testa di Gregorio IX (1227-1241), il committente dell'opera. Una trentina di anni più tardi, Niccolò III (1277-1280) fece erigere la sua cappella gentilizia; forse al pontificato dell'Orsini può ascriversi anche il vasto ciclo ad affreschi dell'atrio, di cui si conservano solo due Apostoli, Pietro e Paolo, opera di un artista attivo tra Roma ed Assisi alla fine del Duecento. Dell'equipe, fu a capo Arnolfo di Cambio, autore del sacello di S. Bonifacio IV, in origine addossato alla controfacciata, andato poi distrutto. Nelle Grotte si conserva solo il sarcofago del committente, Bonifacio VIII (1294-1303).  Durante l'esilio di Avignone (1309-1377), San Pietro mantenne un ruolo importante nel panorama artistico romano, specie grazie al cardinale Jacopo Stefaneschi, che lega il suo nome al mosaico della Navicella, attribuito tradizionalmente a Giotto, e al Polittico Stefaneschi, il grandioso polittico dell'altar maggiore, ascritto anch'esso a Giotto, per le figure del Cristo centrale e della Vergine nella predella; alla bottega si attribuiscono le altre figurazioni, pur di altissima qualità.
Durante l'esilio di Avignone (1309-1377), San Pietro mantenne un ruolo importante nel panorama artistico romano, specie grazie al cardinale Jacopo Stefaneschi, che lega il suo nome al mosaico della Navicella, attribuito tradizionalmente a Giotto, e al Polittico Stefaneschi, il grandioso polittico dell'altar maggiore, ascritto anch'esso a Giotto, per le figure del Cristo centrale e della Vergine nella predella; alla bottega si attribuiscono le altre figurazioni, pur di altissima qualità.Eugenio IV (1431-1447) chiamò Antonio Averlino detto il Filarete per fondare una porta bronzea per ornare l'ingresso principale della basilica, a emulazione delle valve del Battistero di Firenze, realizzate da Lorenzo Ghiberti. Sisto IV (1471-1484) volle Antonio del Pollaiolo per la costruzione della sua tomba, ancora integra e conservata nel Tesoro di S. Pietro. Lo stesso artista realizzò il monumento funebre di Innocenzo VIII (1484-1492).  Al 1499 è datata la celeberrima Pietà di Michelangelo, l'unica scultura firmata dal maestro, destinata, in origine, alla Chiesa di S. Petronilla.
Al 1499 è datata la celeberrima Pietà di Michelangelo, l'unica scultura firmata dal maestro, destinata, in origine, alla Chiesa di S. Petronilla.Il Cinquecento si apre all'insegna dei progetti per ricostruire la nuova S. Pietro; già papa Niccolò V (1447-1455) aveva affidata a Bernardo Rossellino il compito di costruire un grande coro all'esterno dell'abside costantiniana: fu il primo passo verso la demolizione delle antiche strutture. La basilica attuale nacque al tempo di Giulio II (1503-1513), che chiamò Bramante e Michelangelo, autore, inoltre, del monumento funerario, non finito, dello stesso papa. Fu Bramate ad aggiudicarsi l'incarico per il rifacimento dell'intero edificio: concepì un'immensa struttura a croce greca, coperta da una cupola centrale, cui erano correlate altre quattro calotte minori. Quando Bramante morì, nel 1514, i lavori erano già iniziati ed avrebbero condizionato quelli successivi. Raffaello fu il primo a riproporre la pianta longitudinale a croce latina. Alla sua morte, nel 1520, Antonio da Sangallo il Giovane, assumendo l'incarico del cantiere, insieme al Peruzzi, continuò in questa direzione, ma correggendo alcune misure, sopraelevando il pavimento e formando, così, l'immensa cripta delle Grotte Vaticane. Tra il 1538 e il 1543, sotto Paolo III Farnese (1534-1549), il Sangallo elaborò un nuovo progetto, per il quale fece realizzare anche un grande modello in legno, tuttora in Vaticano. Morto di malaria nel 1546, l'architetto non ebbe le fortuna de vedere eseguiti i suoi disegni; il nuovo responsabile, il divino Michelangelo, mostrò sin dall'inizio la ferma intenzione di ricondurre l'impresa ai criteri di limpida monumentalità che aveva improntato l'impianto bramantesco. Degli interventi michelangioleschi oggi si conserva integra la zone absidale, all'esterno. Anche la cupola non rispetta che in parte le intenzioni dell'architetto: autografi sono il tamburo possente a colonne binate che, come un'immensa ruota dentata, sembra catturare in un moto rotatorio il vasto spazio circostante. Prima di morire, Michelangelo diede alle fiamme molti suoi progetti, compresi gli schizzi per la cupola, di cui si è perduto anche il modello in argilla. Si può ricondurre con certezza alla concezione michelangiolesca solo la copertura a doppio guscio, memore della cupola di S. Maria del Fiore del Brunelleschi; il profilo molto rialzato è, invece, opera di Giacomo della Porta, il quale finì la calotta con il lanternino di coronamento. La basilica acquisì la sua veste definitiva al tempo di Paolo V Borghese (1605-1621), che istituì in concorso apposito per al facciata. Al vincitore, Carlo Maderno, che per la nuova facciata di S. Pietro si attenne al lessico buonarrotiano, la Curia richiese anche l'aggiunta dello spazioso corpo longitudinale, finendo però per sconvolgere gli equilibri spaziali calibrati nel corso del XVI secolo. All'interno della basilica, la prima impresa di rilievo fu la cappella di Gregorio XIII (1572-1585), sotto a una delle quattro cupole minori, opera di Girolamo Muziano; essa ristabilì la fortuna della tecnica musiva, prediletta per la sua qualità di resistenza nel tempo. Per il Giubileo del 1600, il mosaico fu adottato anche per la cupola, che venne così decorata da Cesare Nebbia, Giovanni de Vecchi, il Cavalier d'Arpino. Lo stesso papa, Clemente VIII Aldobrandini (1592-1605) fece decorare con mosaici da Cristoforo Roncalli la sua cappella gentilizia, iniziata da Michelangelo e finita da Giacomo della Porta.  Sotto il pontificato di Urbano VIII (1623-1644) la basilica fu nuovamente oggetto di interesse per le grandi imprese decorative promosse dal papa: ad opera di Gian Lorenzo Bernini, incaricato di eseguire il baldacchino in bronzo sotto la cupola, venne realizzata una serie di progetti comprendenti un allestimento decorativo completo di colonne e incrostazioni marmoree, medaglioni colorati e candide statue in marmo di Carrara, per cui la chiesa, nella nuova veste barocca, mostrava grande vivacità cromatica e luminosa. Bernini realizzò anche i due monumenti funebri a Urbano VIII e ad Alessandro VII (1671-1678). Al tempo di quest'ultimo risalgono la Cattedra nell'abside, la complessa macchina devozionale compiuta tra il 1656 e il 1665 per racchiudere il seggio, probabilmente di età carolingia, che la tradizione attribuiva all'Apostolo Pietro, e il celebre colonnato della piazza, l'immensa ellissi, larga 240 metri, costituita da imponenti porticati di colonne doriche, disposte su quattro file. I due emicicli, simboleggianti le materne braccia della Chiesa, hanno anche la funzione urbanistica di raccordo tra la basilica e la città.
Sotto il pontificato di Urbano VIII (1623-1644) la basilica fu nuovamente oggetto di interesse per le grandi imprese decorative promosse dal papa: ad opera di Gian Lorenzo Bernini, incaricato di eseguire il baldacchino in bronzo sotto la cupola, venne realizzata una serie di progetti comprendenti un allestimento decorativo completo di colonne e incrostazioni marmoree, medaglioni colorati e candide statue in marmo di Carrara, per cui la chiesa, nella nuova veste barocca, mostrava grande vivacità cromatica e luminosa. Bernini realizzò anche i due monumenti funebri a Urbano VIII e ad Alessandro VII (1671-1678). Al tempo di quest'ultimo risalgono la Cattedra nell'abside, la complessa macchina devozionale compiuta tra il 1656 e il 1665 per racchiudere il seggio, probabilmente di età carolingia, che la tradizione attribuiva all'Apostolo Pietro, e il celebre colonnato della piazza, l'immensa ellissi, larga 240 metri, costituita da imponenti porticati di colonne doriche, disposte su quattro file. I due emicicli, simboleggianti le materne braccia della Chiesa, hanno anche la funzione urbanistica di raccordo tra la basilica e la città.Al tempo di Urbano VIII, la cappella della Vergine della Colonna venne decorata a mosaico tra il 1629 e il 1632 da G.B. Calandra, su cartoni di G.F. Romanelli, Andrea Sacchi e Giovanni Lanfranco, autore anche dell'affresco La Navicella, oggi nella Loggia delle Benedizioni, e della decorazione della cappella del Crocifisso, dove si trova anche la Pietà di Michelangelo. Pietro da Cortona entrò nel cantiere di San Pietro sin dal 1628, realizzando la Trinità per la cappella del Sacramento. A partire dal 1652 eseguì numerosi cartoni per i mosaici delle prime tre campate di destra, terminati, dopo la sua morte, dall'allievo Ciro Ferri. Verso la fine del secolo si iniziarono a sostituire con copie in mosaico molte pale d'altare, ormai consunte dal tempo. Nel 1709 Francesco Trevisani successe al Baciccia nella decorazione della cappella del Battesimo; i cartoni, a olio, sono conservati nella Galleria Nazionale d'Arte Antica, a Roma. Due anni più tardi, Carlo Maratta, già autore della decorazione della cappella della Presentazione, intervenne anche nella cappella del Coro. Di particolare interesse nel Settecento furono le opere di scultura, quasi sempre legate al tema funebre, come la tomba di Clemente X (1684) di M. de' Rossi, o quella di Innocenzo XI di P.E. Monnot, fedeli al modello berniniano, che resiste fino all'epoca neoclassica con la sola variante dell'aggiunta del modello algardiano. Nacquero così le tombe di Gregorio XIII (1715-1723) di Camillo Rusconi, di Benedetto XIV (1734-1737) e di Maria Clementina Sobievskij, entrambe opera di Pietro Bracci, e, infine, la tomba di Innocenzo XII (1746), di Filippo della Valle. Al termine delle esperienze tardo barocche si pone il monumento di Clemente XIII Rezzonico di Antonio Canova, realizzato tra il 1788 e il 1792, sviluppato intorno alla porta di S. Michele. Quest'opera neoclassica costituì il punto di partenza per le sculture di Thorvaldsen, autore del monumento di Pio VII (1823) e Pietro Tenerani, che realizzò la tomba di Pio VIII (1857). |

Sito a cura di Silvia Zanini
Realizzazione grafica a cura di
