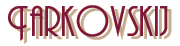Il percorso artistico di Andreij Tarkovskij
Vorrei suggerire una possibile analisi del breve percorso artistico e culturale del più grande regista russo successivo ad Ejzenstein: Andrej Tarkovskij, nato nel 1932, morto nel 1986, figlio di Arsenij Tarkovskij, un poeta minore specializzato in lingue orientali che esordisce contemporaneamente ad Andreij negli anni '60.
Prima di parlare singolarmente delle opere di quello che è stato definito il "regista-poeta", non possiamo non accennare all'importanza e all'influenza che su di lui ebbero, sin dalla sua infanzia, la spiritualità russa come anche lo stesso paesaggio russo, quest'ultimo caratterizzato soprattutto dall'acqua, acqua che si scioglie in mille rivoli, che ristagna, si congela, gonfia i fiumi. Nella pittura russa del XIX secolo l'acqua diviene quasi una protagonista, perché, esattamente come l'icona, è elemento fondante della cultura di quest'immenso paese; in particolare, in tutti i film di Tarkovskij, l'acqua, elemento primordiale, è presente in maniera assai abbondante: spesso piove, i protagonisti vi si trovano immersi, la attraversano. L'acqua di Tarkovskij è sporca, piena di oggetti strani, di rifiuti e di presenze ambigue. Il discorso sul ruolo dell'icona nell'arte russa è invece molto più complesso: i pittori di icone sono in Russia gli Artisti e i Pittori per eccellenza (vedi ad es. "Andreij Rublev"), le loro opere nascono dalla partecipazione alle miserie, alle sofferenze e alle guerre del popolo. I pittori di icone, esattamente come i folli e i pazzi, sono molto frequenti nei film di Tarkovskij, "vedono" con il cuore e raggiungono più velocemente degli altri la verità.
Tarkovskij nasce nel 1932, anno in cui vengono alla luce alcuni tra i più significativi scrittori sovietici, come Vasilij Aksenov o Vladimir Vojnovic; gli anni '50 e '60 sono il periodo della sua formazione culturale, e comincia in Russia un'epoca nuova, chiamata "il disgelo", ovvero la lenta liberazione della cinematografia sovietica dagli schemi rigidi e fissi imposti dalla politica staliniana. Tarkovskij è studente alla Scuola di cinematografia di Mosca quando il culto della personalità di Stalin raggiunge il culmine, e si diploma nel '60, in tempo di disgelo, con il cortometraggio "Il rullo compressore ed il violino", con il quale comincerà la sua carriera cinematografica. Il suo primo film è "L'infanzia di Ivan", del '62, che vince il primo premio alla XXIII Mostra cinematografica di Venezia; la critica italiana lo accusa di essere eccessivamente simbolico ed espressionista, ma Sartre grida al capolavoro. L'aspetto veramente innovativo di quest'opera consiste nell'aver individuato un modo nuovo di raccontare la guerra: "L'infanzia di Ivan" ci ricorda che la guerra è tragica e che la storia stessa (come dice Hegel) è tragica. Tarkovskij si colloca in una prospettiva esistenziale, come fa sempre, mettendosi dalla parte dell'uomo. Infatti lungo tutto il film, che si dispone su due piani, quello onirico (i ricordi e i sogni del protagonista) e quello reale (la guerra), egli racconta il dramma individuale di un bambino, Ivan, rimasto solo e incattivito dalla violenza che lo circonda, senza alcun accenno ad atti eroici, ma semplicemente mostrando il dolore del mondo e quello di Ivan, trasformato in un mostro dal mondo stesso. La morte del bambino viene scoperta casualmente da un soldato sovietico, a guerra conclusa, negli archivi nazisti. La guerra viene vista come male totale e annientatore, ma il nemico non viene mai mostrato: è fatto solo di suoni, di impronte e di altri segni; il nemico è chi si dichiara contrario all'uomo, alla vita e alla libertà, ed è colui che costringe Ivan a pensare continuamente ai suoi anni felici con sua madre, ricordati in modo talmente intenso che sogno e veglia si scambiano di posto in continuazione. La figura materna, inoltre, diventa sorgente di vita associata alla natura, alla terra, all'acqua e alla patria russa. Nei film di Tarkovskij, quindi, si respira un umanesimo di fondo: i suoi personaggi non agiscono nella storia, non la cambiano; il solo motore della storia è la coscienza individuale. Secondo il regista, "il cielo è vuoto"; Tarkovskij infatti respinge Dio, ma accetta l'Assoluto, che può essere conosciuto e avvicinato mediante l'Arte.
Infatti, proprio l'Arte è uno dei temi principali della sua seconda opera, "Andreij Rublev", del '66. E' un film epico, di oltre tre ore, su uno dei più importanti pittori russi di icone della prima metà del 1400. In questo film Tarkovskij si interessa al rapporto tra l'artista e il potere, e tra l'artista e il proprio tempo, la propria epoca, che si sforza di amare e capire. Quest'opera, la cui originalità consiste tra l'altro nel fatto che non si vede mai Andreij dipingere, è realizzata completamente in bianco e nero, esclusi gli otto minuti finali, che riprendono la Trinità e le altre opere dell'artista. Il film si può dividere in due momenti principali: l'assalto dei Tatari alla città di Vladimir (Andreij perderà la propria fede), e la costruzione di una grande campana da parte di un ragazzo (episodio che farà superare al pittore la propria crisi). La funzione e il significato dell'arte sono continuamente esaminati e messi in discussione; il tutto avviene attraverso dettagli e primi piani ma anche con sequenze più lente, ampie ed emblematiche. "Andreij Rublev" è comunque il film più complesso del cineasta russo, essendo stato accettato con difficoltà in URSS soprattutto a causa dell'infedeltà storica e delle riflessioni mistiche del protagonista, preso da una vera e propria crisi esistenziale.
Nel '72 Tarkovskij approda al film di fantascienza con "Solaris", tratto da un romanzo dello scrittore polacco Stanislaw Lem: lontano nello spazio è stato scoperto un misterioso pianeta intelligente, "pensante", in grado di trasformare in realtà i sogni, le paure i ricordi di un gruppo di scienziati di una base spaziale. Con questo film Tarkovskij tenta di indagare la psiche umana con le sue fobie, i suoi traumi, mettendo in diretto contatto gli scienziati con i loro problemi quotidiani e morali. Attraverso i ricordi e le vicende dei protagonisti, il regista crea un'atmosfera onirica: la fantascienza diventa solo una scusa per studiare i pericoli insiti nella scienza e nel progresso e per porsi interrogativi metafisici. Che cos'è Solaris? E' forse Dio? A noi la scelta.
Dopo questo salto nello spazio, Tarkovskij ritorna con "Lo specchio" del '75 ad uno dei suoi temi prediletti: l'infanzia. "Lo specchio" non è altro che un complicato flashback autobiografico, complicato per vari motivi: come anche in molti altri suoi film, ne "Lo specchio" si mischiano e si sovrappongono in continuazione presente, passato e sogno. Anche quest'opera è stata criticata suscitando varie discussioni, specialmente a causa di un certo narcisismo di fondo; lungo tutto il film si snodano la vita di Andreij Tarkovskij e quella di suo padre, il poeta Arsenij: entrambi hanno assistito alla fine del loro matrimonio, e intorno a quest'episodio circola un insieme di ricordi: l'infanzia, la guerra, la solitudine. Un film dedicato alla memoria, intimista ma anche drammatico. Come in "Andreij Rublev", anche ne "Lo specchio" il cineasta tenta un parallelo tra inquadratura e quadro: il protagonista del film (Tarkovskij stesso) si commuove davanti alle immagini di Leonardo, un Leonardo che lo illumina, che improvvisamente regala un senso alla sua vita. I quadri di Tarkovskij, inoltre, hanno una loro durata, una loro vita silenziosa, e d'altronde, per il regista, il cinema stesso è pittura tridimensionale, scultura nel tempo. Il tempo è la materia del cinema, il cinema, cioè, è fatto di tempo e l'immagine diviene realmente cinematografica non solo se vive nel tempo, ma se il tempo vive in essa. Dice Tarkovskij nel suo libro "Scolpire il tempo": "Il montaggio può essere definito un metodo di collegamento dei singoli brani tenendo conto della pressione del tempo all'interno di essi".
Passiamo adesso al 1979, anno di uno dei film più belli di T.: "Stalker". Prima di parlare direttamente di quest'opera bisogna fare un piccolo passo indietro. A partire da "Solaris", ma anche ne "L'infanzia di Ivan" e in "Andreij Rublev", Tarkovskij è interessato a sottolineare il decadimento e la fragilità della natura umana, e soprattutto i pericoli per l'uomo di cadere nel subumano; il regista si barrica nel tunnel, nell'incubo, all'interno di presenze fantastiche. I suoi eroi non hanno difficoltà da superare, ma sono vinti in partenza; infatti in molti film sono presenti infermità e malattie: ad es. il prologo di "Lo specchio", il pazzo di "Andreij Rublev", il personaggio di Domenico in "Nostalghia". In "Stalker" il disfacimento è continuamente accennato attraverso i vestiti stropicciati dei protagonisti, la sporcizia, le barbe non rase. Lo Stalker è una sorta di guida che conosce i segreti della "zona", una regione radioattiva abbandonata dagli uomini. All'interno della "zona" sorge un edificio, nel quale si dice vi sia una stanza in cui si realizzano i desideri. Uno scienziato e un romanziere chiedono l'aiuto dello Stalker e si addentrano nella "zona" per esplorarla e giungere alla fantastica stanza. I tre sono molto diversi tra loro; interessantissime sono le domande che si porgono l'un l'altro durante l'estenuante camminata. E' un film lirico, in cui la natura sembra ribellarsi alla cultura: lo Stalker, rozzo ex galeotto, nella sua semplicità pare essere molto più ricco degli avidi intellettuali che hanno perso l'ispirazione. All'apparenza nel film non succede niente, tanto che Tarkovskij definisce "Stalker" "un film d'azione interiore, un western del cervello". Giunti alla soglia della stanza i tre rinunceranno ad entrare, per tornare indietro alla loro vita di sempre. Lo spettatore (come i protagonisti stessi) non saprà mai se i tre abbiano assistito ad un sogno, un incubo, o un'allucinazione. Lo scopo di Tarkovskij in quest'opera consiste nell'individuare e nel descrivere quel qualcosa che permette agli uomini di realizzare le proprie aspirazioni e i propri progetti.
Nel 1983 Tarkovskij lavora al suo penultimo film, "Nostalghia", girato in Italia per la RAI. Come ci ricorda Goffredo Fofi, "Nostalghia" è un canto d'amore per la Russia lontana, dove l'autore non trova più lavoro né pubblico. La nostalgia che si avverte e che viene descritta è quella per la Casa, anche se il film ci presenta costantemente case distrutte, allagate, cadenti; la Casa che si trova spesso citata e raccontata nella poesia di Arsenij Tarkovskij rappresenta in una sola volta la sicurezza, la madre, la fecondità, il tepore. Tema di "Nostalghia" è il viaggio, specialmente visto come ripensamento su se stessi e sul proprio modo di essere e di presentarsi agli altri. Il poeta russo Gorciacov si trova in Italia per scrivere la biografia di un musicista russo del passato, ma una serie di situazioni, di ricordi, di problemi generano in lui un'emozione sconosciuta: la "nostalghia" per la sua terra lontana. Il poeta sarà completamente in preda a questo sentimento tanto da mischiare e confondere sogni, ossessioni e memorie del suo passato e della sua vita. Passato e presente vengono a fondersi nella mente del protagonista continuamente, e lo rendono apatico e passivo; solo un uomo riesce ad attrarlo e scuoterlo: il folle Domenico, che predica l'amore e la comunione tra gli uomini. Anche in quest'opera Tarkovskij pare sondare ed indagare con curiosità e profondità le lacerazioni e la morte dell'animo di che è lontano dalla propria patria e dalla propria casa, di chi non riesce più ad instaurare con il prossimo (in particolare Eugenia, l'interprete del poeta) un rapporto sincero e duraturo. E' soprattutto interessante ricordare la presenza in molte sequenze dell'acqua e della pioggia, la freddezza degli ambienti, l'inospitalità dei luoghi visitati dal poeta.
Anche l'ultimo film di Tarkovskij riflette la voglia e il bisogno da parte dell'uomo di comprendere il mondo e il senso della vita: si tratta di "Sacrificio" del 1986, film colto e letterario assimilabile ad alcuni film di Bergman (come, ad es., "Il silenzio"). La storia si svolge all'interno di una famiglia in cui si assiste ad un moltiplicarsi e intrecciarsi di ossessioni e paure dovute alla minaccia di un imminente disastro nucleare. Il professor Alexander intende sacrificarsi per il bene dell'umanità ormai priva di ideali e di fede; egli viene isolato, incompreso, e trattato come un pazzo. "Sacrificio" è anche però la summa della poetica del cineasta: una storia di olocausto, in cui Alexander rinuncerà ai propri beni, alla propria libertà e alla parola per salvare tutti gli uomini. Figura altrettanto emblematica di quella del protagonista è il figlioletto di quest'ultimo, da tutti chiamato "ragazzino", che, all'inizio del film, pianta con il padre un albero; "Sacrificio" si chiude con l'immagine del bambino che innaffia la pianta sedendosi accanto al tronco e guardando un cielo ritornato quieto e azzurro, mentre l'ambulanza porta via il vecchio ormai folle: l'olocausto di Alexander è compiuto. Ora la vita può continuare, mentre il comportamento apparentemente irrazionale di Alexander si inserisce nel tentativo emblematico di sottrarre il mondo al flusso degli avvenimenti e della storia.
Bibliografia:
Bernardi S., "Introduzione alla retorica del cinema"
Caldiron O. (a cura di), "Tarkovskij e la critica", dispense
Rondolino G., "Storia e critica del cinema"
Tarkovskij A., "Scolpire il tempo"
|