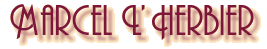L'incontro con Luigi Pirandello
In questo percorso Marcel L'Herbier incontra il romanzo di Luigi Pirandello: il Fu Mattia Pascal.
E' il 1925 e non e' un caso che Marcel L'Herbier decida di dedicarsi alla trasposizione cinematografica di un noto romanzo, in quanto in passato si era gia' cimentato in operazioni di questo genere.
Piramndello e' ben felice che Marcel L'Herbier realizzi un film sul suo famoso romanzo:<<Il cineasta del Don Juan e del Faust sapra' mettere nella realizzazione del film cio' che manca al romanzo, ma riuscendone a conservare il soggetto originale. Per la prima volta ho fiducia nell'arte muta>>.(L. Sciascia, Il volto sulla maschera, Milano Mondadori 1980, pg.14)
Ed infatti ne risultera' un film sicuramente innovativo, tutt'altro che banale, in cui l'impiego dei mezzi cinematografici assume tono deciso e perfetto, e d'altronde la duplicita' del personaggio di Mattia e' un fertile terreno per lo sperimentalismo di Marcel L'Herbier, che infatti trova in Pirandello uno degli ultimi narratori del fantastico: il romanzo ci presenta la trama ideale per creare un intrigo paradossale che possa essere dispiegato in chiave fantastica, ma quotidiana e realistica nello stesso tempo.
Nonostante il successo del film, alcuni critici hanno fatto notare come esso presenti un carattere frammentario, ricco di particolari sviluppati fino all'eccesso a scapito della vicenda generale, con effetti tipicamente cinematografici, sicuramente efficaci, ma che rendono piu' lenta l'azione; un esempio di questa discontinuita' e' dato dalla presenza di continui spunti comici: l'inseguimento accelerato di una donna in Trinita' dei Monti, la lotta con i topi in biblioteca, la designazione della camera nella pensione romana quando Mattia cerca di entrare in ogni porta, ma non e' mai quella giusta, il suo ritorno a casa nelle vesti di un vendicatore che provoca uno spavento eccessivo della vedova Pescatore etc. D'altra parte sembra che Marcel L'Herbier non voglia lasciarsi sfuggire nessuna occasione per fare del cinematografo, anche a costo di fare del film una serie di episodi distaccati; probabilmente sono proprio queste imperfezioni che rendono cosi' originale la lettura che Marcel L'Herbier ha dato del Fu Mattia Pascal; la critica e' unanime nel constatare l'aggiornamento che il regista ha effettuato negli anni '20 sull'opera pirandelliana, non dimentichiamo infatti che il film esce nel 1925, dopo piu' di 20 anni dalla pubblicazione del Fu Mattia Pascal, la cui vicenda se innovativa nei primi anni del novecento, nall'arco di due decenni perde parte della sua originalita' agli occhi delle nuove generazioni (ormai smaliziate dal diffondersi delle idee Freudiane, dalla psicanalisi e dalle avanguardie artistiche).
Alla luce di quest'aggiornamento e' necessario dire che Marcel L'Herbier e' molto sagace nel notare che il Fu Mattia Pascal e' un romanzo che va verso il cinema, in quanto ci sono continui riferimenti alla vista e al vedere (gli occhiali, l'occhio strabico, il lanternino) che sostanzialmente vogliono far capire come gli occhi molto spesso non siano altro che i percettori di un senso ingannevole. D'altra parte la stessa doppia essenza di Mattia Pascal e' illusoria e per questo votata al cinema, che per sua natura e' l'arte dell'illusione, ma mentre il romanzo si regge sul raddoppiamento (Adriano/a, le due gemelle, le due paternita', i due fratelli, la durata di tutta la vicenda di due anni e due mesi etc.) sostenuto dal vedere storto di Mattia, nel film questa ossessione per il doppio viene eliminata, anche se il fulcro su cui ruota la vicenda e' sempre costituito dallo sdoppiamento della personalita' di Mattia, che assumera' un'altra identita' nella figura di Adriano Meis, sara' solo questione di un nome, perche' il suo aspetto fisico rimarra' identico: non si tagliera' la barba, non si fara' crescere i capelli, non portera' gli occhiali azzurri e soprattutto non raddrizzera' l'occhio in quanto non lo ha mai avuto storto.
Il personaggio rimarra' fedele a se stesso, infatti il regista per rendere l'idea della doppiezza deve ricorrere ad un trucco cinematografico: la doppia immagine.
Un'altra differenza tra il film ed il romanzo e' che il primo non e' mai raccontato sotto forma di ricordo, quindi di autoriflessione, in quanto Marcel L'Herbier elimina il flashback, e quindi Mattia e' visto dall'esterno e vive la sua vicenda "in diretta" assieme al pubblico che segue la storia. Mattia non puo' imporre la sua visione distorta e strabica del mondo, che invece nel romanzo era simbolicamente rappresentata dal suo strabismo.
Tutto cio' non impedisce al regista di fare in modo che nella vicenda di Mattia, la realta' sia quasi piu' fantastica della fantasia stessa, proiettando i fatti su uno sfondo quasi soprannaturale; anche il finale a carattere prevalentemnte simbolico e' perfettamente intonato con il resto del film: in un finale quasi chapliniano Mattia si allontana verso il futuro e la nuova vita.
Per quel che riguarda gli altri protagonisti della vicenda, la vedova Pescatore, Papiano, la signorina Caporali e' curioso sottolineare come le loro descrizioni disegnate da Marcel L'Herbier corrispondano in maniera impressionante al tipico italiano del sud: bassi, tarchiati, scuri di pelle ed in viso, rozzi etc; non che la signorina Caporali da Pirandello sia descritta come una donna bellissima, ma neanche cosi' grassa, viscida e ripugnante come l'attrice che l'interpreta; Papiano non e' un personaggio simpatico, ma non e' cosi' volgare e rozzo come lo descrive Marcel L'Herbier.
Al contrario, Adriana e' rappresentata in maniera fin troppo docile e timida. Anche nel romanzo ha un temperamento simile, ma nel film si presenta addirittura priva di consistenza, senza alcun peso determinante nelle azioni di Mattia.
|